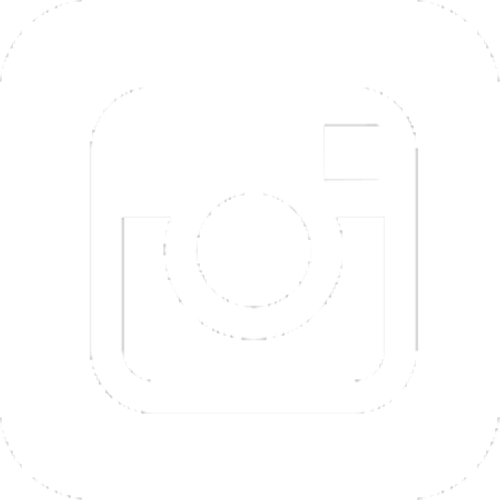È passato più di un secolo da quando l’arte è uscita dal quadro (o fuori sesto per chi rimpiangeva il perimetro della tela) e uno scolabottiglie è stato incoronato dalle muse, anzi dall’unica musa che si è auto investita del compito: l’artista (Marcel Duchamp, 1914).
E ben più di cinquant’anni sono trascorsi da “quando nuove forme espressive, basate soprattutto su elementi concettuali, teoretici, noetici, hanno preso il posto di quelle ancora basate sull’uso di mezzi espressivi pittorici e plastici” (Gillo Dorfles, 1973).
Tra queste nuove forme espressive, il cui catalogo nominalistico è così ricco da lasciarci stupiti per come lungo i secoli ci si fosse accontentati di poche generalissime definizioni -pittura, scultura, architettura- per includere tutto il lavoro artistico, c’è, tra queste forme, la land art.
La land art che postula un intervento dell’artista sulla natura e nella natura, oltreché del quadro si è liberata anche dell’atelier, dello studio, del loft, insomma dello spazio sacro dell’autore.
L’arte perde il suo oggetto, perché il suo oggetto diventa il paesaggio, il mondo intero volendo, e l’intervento che il gesto creativo compie sulla natura produce un risultato più intellettuale che estetico. O quantomeno la rappresentazione posta in atto è potenziata da un corposo racconto teorico. Nella concretezza delle opere è invece facile vedere la differenza estetica tra una installazione di Christo (vedi la recente passerella sul Lago d’Iseo o le sue sontuose impacchettature di grandi superfici architettoniche) e Line Made by Walking (1972) di Richard Long, una striscia di erba calpestata.

(Photo by Marco Bertorello/AFP/Getty Images)

La land art ha una famiglia alle spalle, i giardini zen giapponesi, i parchi all’italiana o all’inglese ecc, ma è una famiglia da cui ha dirazzato per motivi politici e filosofici: non ha (meglio, non dovrebbe avere) fini ornamentali o ricreativi, ma piuttosto saggistici. Vuole riflettere sul rapporto tra uomo e natura, tra uomo e ambiente e ai suoi esordi era forte la denuncia di come in questi rapporti l’uomo avesse un ruolo distruttivo e auto distruttivo.
Olafur Eliasson, per i suoi lavori dedicati al degrado degli ecosistemi, al risparmio energetico, all’inquinamento, ma anche con la sua Fondazione che in Etiopia si occupa della formazione di operatori per gli orfanotrofi del paese, è un ottimo esempio di questa tipologia di artista coinvolto politicamente dal contesto in cui si esprime e agisce. Nel 1988 con un intervento paradossale ha colorato di verde l’acqua di molti fiumi in giro per il mondo, adoperando l’uranina, una sostanza impiegata per la rilevazione delle correnti marine. I suoi Green Rivers si sono snodati come un segno iperecologico/iperreale/ipercontraddittorio nel movimento indifferente di corsi d’acqua spesso inquinati.

Tim Pough che si definisce environmental artist ci riconduce però, a testimonianza di una gamma di esperienze molto diverse, a una pratica artistica più convenzionale dove l’oggetto estetico riprende baldanza. Seppure si tratti di un albero, di una serie di foglie o pietre o bicchieri di plastica colorata: geologia, storia, ecologia si mescolano in segni e forme apertamente decorativi.


Il paesaggio, manipolato e fotografato, diventa un effetto speciale nei lavori di Zander Olsen. Il bosco si sottomette come un attore a un regista per mettere in scena una fairie che ha lo scopo di sbalordire lo sguardo.


Meno radicale, più coreografico, leggero e appetibile, Stephen Duneier (Yarnbomber) nel 2012 ha vestito con un patchwork coloratissimo un eucalipto al Cold Spring Trail’s East Fork tra le montagne di santa Barbara in California, dopo aver imparato a lavorare a maglia per l’occasione. L’installazione temporanea è durata per nove giorni, dopo i quali l’albero è stato spogliato della sua muta artistica senza conservarne alcuna traccia.

Ma l’albero, forse per la sua immediata forza simbolica – radicato nella terra, quanto slanciato verso lo spazio aperto – è vittima privilegiata anche dell’australiano Kostantin Dimopoulos che descrive così i suoi intenti: “Nella mia installazione ambientale, The Blue Trees, il colore e l’albero diventano una cosa sola e si influenzano l’un l’altro; il colore cambia l’albero in qualcosa di surreale, appartenente a un altro mondo. Allo stesso tempo l’albero, ben radicato in questa terra evoca ciò che noi possiamo perdere”.



Non so se l’omaggio agli alberi blu di Paul Gauguin sia del tutto casuale.

L’operazione di Dimopoulos che coinvolge nelle sue azioni anche il pubblico, sembra smarginare nella living art sotto quella particolare specie che Harold Rosenberg, critico d’arte del New Yorker, nel 1972 identificava nel World Game di Gene Youngblood, la cui “attività formale consiste nel comporre «sceneggiature geosociali» con le quali trasformare l’ambiente/realtà”. In questo progetto non importano i nomi perché c’è posto per tutti. Non è più l’artista ad essere importante, né la sua perizia tecnica, ma l’idea. Più questa idea sarà di facile applicazione da parte di chiunque, più la trasformazione del mondo sarà effettiva.
Rosenberg apparentava il World Game al Teatro Natura dove “vi sono attori, ma non necessariamente spettatori” (H. Rosenberg, 1975).
Il Teatro Natura di Oklahoma è quello inventato da Franz Kafka nel romanzo America: il protagonista Karl Rossmann scruta un manifesto che ne annuncia la presenza all’ippodromo di Clayton: “Tutti sono i benvenuti! Chi vuole divenire artista si presenti! Noi siamo il teatro che serve a ciascuno, ognuno al proprio posto! Diamo senz’altro il benvenuto a chi decide di seguirci!”. Tutti possiamo essere artisti, anzi tutti siamo un’opera d’arte. Al nostro posto nel museo del mondo.
Nel caso di Lionel Esteve gli elementi di natura invece diventano semplicemente funzionali al suo eclettismo compositivo: è una land art miniaturizzata e straniata perché il paesaggio ha esattamente i confini dell’opera, quando non di un quadro. La natura non è più un polo dialettico ma una cava di materiali d’uso.


Se Esteve parassita la natura, la estetizza e la porta in galleria da dove Richard Long l’aveva fatta fuggire, con soddisfazione di entrambi e nostra, Giuliano Mauri ha deciso invece di collaborare con lei, di affiancarla in veste di costruttore, dopo essere stato negli anni Settanta voce di denuncia per le scelleratezze che l’uomo la costringeva subire.

Nelle performance biologicamente degradabili di Nils Udo c’è una pulsione didattica rivolta alla natura: sembra volergli insegnare quanta bellezza artificiale sia contenuta, come opera potenziale, nella sua infinita ricchezza di forme e colori. I suoi interventi sono spesso fragili ma contengono l’ombra di un racconto, di un mistero, la traccia di un romanzo appena concluso o in attesa di essere svelato.


Ma tutto il mondo è parte del Teatro Natura dell’Oklahoma e la città non meno dei vulcani o delle foreste. Lasciare un segno, flettere il tempo con interventi che cambiano provvisoriamente il fronte di un caseggiato o che disperdono nelle strade apparizioni colorate e momentanee, per riportare poi tutto alla condizione precedente, rendendo così possibile il ritorno al passato o la prefigurazione di un futuro ancora precoce: così è stato il lavoro di Franco Summa.


L’idea è l’opera, nessuno è solo spettatore.

Città Sant’Angelo 1975

Intervenire oggi nelle strutture urbane è certo più difficile, anche se la ipersignificazione attraverso elementi provvisori fortemente iconici non è una pratica superata. Basti riandare alla mostra personale di Ai Weiwei inaugurata a Firenze a Palazzo Strozzi nel settembre 2016. La sede espositiva era stata decorata all’esterno dall’artista con quindici (diciotto?) grandi gommoni del tipo usato dagli scafisti per il trasporto dei migranti. Il significato politico di questa installazione site specific era stato messo in forma sfruttando l’analogia tra la forma delle imbarcazioni e l’arco a tutto sesto delle finestre sulla facciata dell’edificio. È ancora il Teatro Natura a fare capolino, se si pensa che secondo Walter Benjamin “una delle funzioni più significative di questo teatro è quella di dissolvere gli accadimenti nelle loro componenti gestuali”. O di dissolvere le sofferenze nell’estetica?

Con minore presunzione, ma fingendo di credere che nel World Game dell’arte siamo tutti artisti, tutti cambiamo continuamente il volto del nostro ambiente interagendo con esso, niente ci impedirebbe di sistemare piccole piante colorate nel cuore di quartieri intristiti dalla monocromia del cemento, o appostare lupi di cartapesta nei giardini striminziti abitualmente frequentati solo da gatti insolenti, o distribuire in file ordinate su qualche strada pedonalizzata teorie di pietre colorate per far ritrovare la via della favola a tutti i Pollicini smarriti delle nostre città, o far la guerra alle insegne che non ci piacciono pavesando le strade con arcobaleni di seta, o appiccicare agli angoli della via occhi di carta che si prendano il tempo di guardare anche quelli che vivono da invisibili, o appendere ai rami degli alberi piccoli campanelli che suonino con il vento lasciando il silenzio senza spartito.
Sono giochi del Teatro Natura dove “ciascuno può creare la propria parte e il proprio modo di interpretarla”, ma sono giochi però che se presi sul serio sono molto più divertenti (e senza l’ansia che qualcuno si affatichi a giudicarli e a interpretarli).