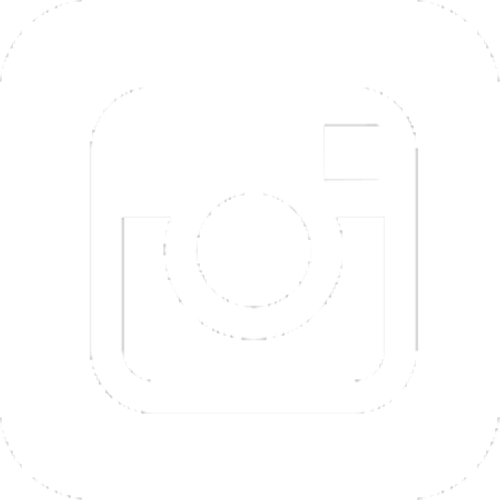“Senza la neve, l’inverno è una bugia”: a quale genere di menzogna sta alludendo il verso di Emily Dickinson? Con quale spirito reagirebbe a questa poesia un bambino vissuto su un’isola caraibica o nel folto della foresta equatoriale? Probabilmente con la fiducia nella verità finzionale di cui parlava Umberto Eco nelle sue lezioni americane. Leggendo una storia, mentre sospendiamo volentieri l’incredulità e accettiamo la verosimiglianza di quello che vi accade, abbiamo bisogno che lo sfondo su cui si staglia ci sia famigliare. Per venire all’esempio fatto, il piccolo lettore della Dickinson deve conoscere la parola neve e sapere a cosa corrisponde.
Ma ci siamo distratti: la bugia cui allude la poetessa americana è del tipo che s’accampa sotto i vessilli dell’inganno. In questa compagine possiamo accogliere anche Odisseo che interrogato da Polifemo su chi gli abbia sconciato l’unico occhio, risponde Nessuno: una doppia bugia, il suo nome è un altro e il nome che sceglie non è un nome. Così quando il ciclope chiamerà in aiuto i fratelli mentirà (nessuno mi ha fatto questo), dicendo la verità (è stato Nessuno). L’inganno è come un sasso che rotolando a valle porta con sé mezza montagna. Anche Hansel adopera la bugia che inganna: nella favola dei fratelli Grimm porge alla strega, ansiosa di cucinare un bambino grassottello, un ossicino invece del suo dito polputo. Ma aveva imparato a mentire dai genitori che avevano promesso a lui e alla sorella di non abbandonarli. Eterogenesi dei fini.

Ma la sua furia è ingannata dalle bugie dell’eroe greco. L’incisione è opera di Theodor Thulden (1606- 1669)
Pinocchio invece è uno strenuo difensore della bugia che nasconde, la bugia che prospera nel senso di colpa e si fa corpo, il naso lungo e le gambe corte: in questo caso la verità matura gloriosamente la sua vendetta psicosomatica. Pinocchio non è un bravo bambino e ha un sacco di ‘genitori’ che hanno bisogno di un bambino perfetto: Geppetto, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Merlo Bianco. Pinocchio non vuole deluderli e allo stesso tempo vuole essere come il suo fratello maggiore Lucignolo, infrangere tutte le regole. La bugia che nasconde è la più tenebrosa e gravida di conseguenze: costringe a una doppia vita.

Eroe eponimo dell’ultima specie di bugie di cui abbiamo detto, le bugie che inventano, è Il barone di Münchausen creato da Rudolf Erich Raspe. Scriveva Mario Lavagetto nel suo indispensabile libro sulla bugia in letteratura, La cicatrice di Montaigne, che lo scopo di Münchausen «non è certo ingannare i suoi lettori; se mai è di scommettere sulla loro disponibilità a lasciarsi trasportare nell’atmosfera ilare e rarefatta delle sue storie. Le sue menzogne trovano nella figura dell’iperbole – una figura innocente e che mal si presta agli intenti del vero bugiardo- un dispositivo di autodistruzione, né a minacciare quel dispositivo c’è, come in Luciano, l’incombenza di un paradosso disgregante e sempre pronta a risorgere». Il Luciano di cui si parla è Luciano di Samosata che premise alla sua Storia vera la dichiarazione che nulla di ciò che avrebbe raccontato sarebbe stato vero.

Il barone di Münchausen è un affabulatore compulsivo che inganna il suo pubblico
passando con disinvoltura da un’invenzione all’altra
Anche il piccolo Calvin che sulle strisce (da tempo interrotte) di Bill Watterson vive in simbiosi con una tigre immaginaria che si chiama Hobbes, come il filosofo che considerava la menzogna indispensabile per definire dei criteri di verità almeno in politica, è un bugiardo costruttore di mondi paralleli in cui dare vita attiva a quel sé che non si può esprimere essendo ciò che si è (nel caso di Calvin un bambino di forse sei anni, che non può gettarsi nelle cascate all’inseguimento di un caimano gigante e combattere nell’iperspazio contro alieni disgustosi o guidare una spider del ’56).

Della sua specie era anche il Tom Courtenay protagonista del film di John Schlesinger Billy il bugiardo (1963), che oppresso dal conformismo, dalla monotonia o dalla mancanza di vero talento fa fiorire dalla realtà le bugie della sua immaginazione: si guarda allo specchio immaginando di essere Napoleone, fuma una patatina come fosse un sigaro, quando nel mondo vero è con le spalle al muro finge di essere un guerrigliero con il mitra in mano. Billy lavora in un’impresa di pompe funebri e ha della pessime relazioni (non ha comunicazione alcuna) con la famiglia. Mentire è il suo modo di dire la verità: vi odio, vi detesto, vi disapprovo.
La bugia ‘che inventa’ è spesso l’espressione di una verità che non trova altra via di salvezza.

Il tradimento delle immagini è un quadro dipinto tra il 1928 e il 1929 da René Magritte: uno dei molti realizzati tra il 1926 e il 1966 in cui appare una pipa o più di una. Sotto l’immagine dello strumento da fumo è scritto in un bel corsivo: “Ceci n’est pas une pipe [Questo non è una pipa]”. Certo che non lo è, è solo un’immagine e per noi che abbiamo ricavato la riproduzione dallo schermo di un pc, è l’immagine di un’immagine. Il quadrato di una bugia se ci riferiamo all’oggetto che ha posato per il quadro, se un oggetto c’è mai stato. Perché dunque quella didascalia ci colpisce? Perché crediamo alle bugie, quando sono verosimili. La verosimiglianza è per noi la verità, quella è una pipa, è il segno di una cosa. Michel Foucault nel 1973 ha scritto su Magritte e le sue pipe un libretto avvincente ed erudito che ci spiega come proprio quell’indissolubile legame tra segno e cosa è stato spezzato dal pittore. Non c’è nessuna pipa, il quadro non è una pipa e la verosimiglianza è una bugia. Non c’è nessun legame naturale tra la cosa rappresentata e la sua rappresentazione. È esattamente l’opposto di quello che accade quando un bambino disegna tre righe circondate da piccoli shrapnel di colore e ci dice che si tratta della sua famiglia durante una meravigliosa gita al lago (il lago è quel triangolo sghembo messo dove noi avremmo messo il sole o la punta di una montagna): lui ‘vede’ un legame necessario tra il segno e la cosa, anche se solo lui potrebbe riconoscere la cosa-mamma nel segno-shrapnel.

Nel 2014 un’impresa di giocattoli giapponese, la Takara Tomy, ha prodotto con un certo successo un fiuta bugie (lie-detector) portatile chiamandolo Kokoro Scanner, che vuol dire più o meno cardiogramma. Lo strumento si applica sulla fronte e registra attraverso i raggi infrarossi il variare delle pulsazioni durante una sequenza di domande e risposte: funziona in parte come i poligrafi che abbiamo visto usare al cinema con il nome di macchina della verità. La prima volta che s’indossa, il Kokoro scanner definisce una sorta di media del battito del cuore: alla prima domanda comparerà questo valore con quello prodotto nel soggetto interrogato. Se la luce prodotta dallo strumento posizionato sulla fronte di chi risponde sarà verde, significa che dice la verità e che le sue pulsazioni sono rimaste invariate, il giallo indica la possibilità di menzogna, il rosso che sicuramente mente. È solo un gioco di società ultra-tecnologico che applica la vecchia regola di Pinocchio: le bugie allungano il naso. In questo caso fanno correre il polso e accendono una luce porporina.
Mario Lavagetto nelle ultime pagine del suo libro, con le parole Marcel Proust ci dice che la bugia “è una delle sole cose al mondo che possa aprirci delle prospettive sul nuovo, sull’ignoto, che possa far schiudere in noi dei sensi addormentati per la contemplazione di universi che non avremmo mai conosciuto”.
Le parole che mentono sono quelle che meglio ci raccontano le verità che non possono essere dette, perché conservano di esse una traccia purificata, essenziale, impossibile da nascondere.