“Circondati da un mondo di giganti, i bambini si creano nel gioco un loro piccolo mondo su misura”.

L’incertezza su quale sia la serratura giusta da aprire per entrare nel meraviglioso, è evidente.
Lo ha scritto Walter Benjamin e probabilmente tutti abbiamo fatto esperienza da adulti della sorprendente ingannevolezza dello spazio, la misura del quale non prevede solo il calcolo di altezza, lunghezza e profondità ma anche l’uso della memoria. Ritornati dopo molti anni in un luogo dell’infanzia abbiamo trovato le nostre strade improvvisamente rimpicciolite come nel mondo di Alice. Presi dalla sindrome di Gulliver abbiamo contato a passi una distanza che ci richiedeva pomeriggi avventurosi per essere percorsa. Quasi fossimo Pollicino dopo che ha calzato gli stivali delle sette leghe, in un attimo dalla porta di casa siamo arrivati alla scuola e poi al parco, dove però quella che era stata la nostra foresta di Brocéliande si è trasformata in un boschetto di allori da cui non ci aspettiamo più che sbuchino all’improvviso Merlino o la Dama del Lago.

In quel momento mentre viviamo contemporaneamente il momento presente e quello passato, riaffiorato in modo automatico al ricordo, sperimentiamo contemporaneamente due percezioni differenti, abolendo l’arco temporale che le separa.
È l’istante in cui la memoria, per solito impegnata a mescolare immagini, volti, frammenti e voci, senz’ordine e completezza, resuscita trasformata in dato di percezione concreto, limpido, univoco. Per una volta, pulito lo schermo da ogni altro ricordo, torniamo a sentire e non solo a sapere cosa vede un bambino, o meglio il bambino che siamo stati.
Sono momenti rarissimi, troppo velocemente dimenticati, ma di cui un’altra memoria ha fatto tesoro: quella, più acuta e lungimirante, dell’arte e della letteratura. La dismisura da cui i bambini cercano rifugio nel gioco, nella letteratura romantica è diventata oggetto di Sehnsucht – nostalgia di ciò che non si è mai conosciuto. Spesso i personaggi di quei libri vivono la condizione sperimentata dal protagonista di Maestro Pulce di E.T.A. Hoffmann, Pellegrino Tyss, al cui animo parlava “solo il meraviglioso, che commoveva la sua fantasia e in cui egli viveva e si animava”. Pellegrino Tyss cerca, e non può riuscire in quest’impresa, di continuare a vivere nell’infanzia circondato dalle sue magie. Il primo struggimento amoroso lo fa vergognare dei giochi sino ad allora così necessari, ma insieme alla vergogna subito l’opprime anche un acuto rimpianto. Il rimpianto del mondo smisurato dove ombre, oggetti, persone, alberi, animali, emozioni, hanno proporzioni colossali o infinitesimali: e dunque ecco un affollarsi di giganti e di minuscoli eroi, pollicini, puccettini, mignoline che dormono in malli di noce, gnomi e orchi spaventosi, pronipoti di Polifemo e antenati di Goldrake. Per chi non soffra, o goda, della follia di Pellegrino Tyss e per tutti i bambini, ci sono le favole per raccontare che c’è o c’è stato un mondo in cui le persone sono grandi come montagne o piccole come un seme di mela, dove certe distanze richiedono anni di viaggio e lontananze siderali si possono colmare con un piccolo balzo.

Secondo Leslie Fiedler, il critico americano che nel 1978 ha scritto un libro intitolato Freaks. Miti e Immagini dell’io segreto, i bambini vivono in una costante incertezza su cosa sia bizzarro e cosa sia normale. Per essi il confine, che per noi adulti sembra essere certo, tra il mondo quale ci appare e quello in cui esercita il suo potere il Mago di Oz, vola per l’aria Peter Pan, precipita Alice o compie i suoi viaggi Gulliver, non è così impenetrabile. E la prima fonte di confusione sono proprio le proporzioni: i giganti e i nani sono le metafore viventi dell’incubo delle dimensioni. Scrive Fiedler:
“… il bambino può essere arrivato a pensare che, in confronto a un adulto, è anche lui un nano, mentre diventa un gigante se paragonato a un neonato o al se stesso di un anno prima. Nel profondo della sua coscienza, continua dunque a ingrandirsi o a rimpicciolirsi, a seconda del contesto e dell’occhio in cui si vede riflesso. -Ma io sono realmente e veramente grande oppure piccolo oppure giusto? non fa che domandarsi, anche quando ha smesso di crescere e comincia, o almeno può sospettarlo, ad accorciarsi”.

Fuori dalle pagine, sulla tela, il pittore tedesco Caspar David Friedrich, vissuto tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, si sforzava di ricreare con la complicità della natura la spaventata gioia del bambino davanti a un picco alpino, al mare, a un bosco intricato, a un fiume tambureggiante o alla neve, d’imitare la sua incerta consapevolezza di cosa fosse davvero grande. O grandioso. Ecco allora oceani di ghiaccio, vette terrificanti e distese incommensurabili. Sembra quasi che Friedrich o i paesaggisti che negli stessi anni per primi hanno dipinto l’inesplorato oriente nordamericano, cercassero di tornare all’esperienza del bambino che con il suo fantastico metro interiore misura l’orizzonte, trovandolo invariabilmente immenso.


Smithsonian American Art Museum, Washington, DC.
L’idea di Maria Montessori che il mondo delle cose intorno ai bambini si dovesse far piccolo è stato un passo da gigante nella pedagogia e nel diradare gli incubi dimensionali dei piccini. Oppure ha suscitato in loro l’idea che anche le sedie e i tavoli si dibattevano nell’incertezza di essere grandi, piccoli o giusti?
Jonathan Swift dava ragione alla filosofia quando questa sosteneva che nulla è piccolo o grande se non per comparazione: Lilliput e Brobdingnag sono una lezione di tolleranza impartita dalla fantasia. Ogni lettore nel rassicurante tepore del libro di Swift potrà essere di volta in volta colui che guarda il mondo dal basso, messo in ombra anche da un filo d’erba, e colui che lo guarda dall’alto, (ir)responsabile della propria forza e pericolosità.


Non si può dire sia un momento basso nelle sue avventure, ma certo è una non piccola lezione.
Le dimensioni sono un effetto ottico morale. O solo un effetto ottico. La stanza eponima inventata dall’oftalmologo Edelbert Ames, ad esempio, ci appare come una qualsiasi stanza in forma di parallelepipedo con pareti laterali parallele, una parete di fondo e un soffitto e un pavimento anch’essi tra loro paralleli. La pianta della stanza in verità è un trapezio, le pareti sono divergenti, pavimento e soffitto sono inclinati. Grazie a questa speciale conformazione dell’ambiente, due persone situate agli angoli opposti della stanza ci appariranno l’una gigantesca e l’altra minuscola. Ancor più sorprendente, vedremo una stessa persona che si sposta da un angolo all’altro ingrandire o rimpicciolire a vista d’occhio.

nel Parc de la Villette a Parigi. Una ripresa filmata piuttosto sorprendente dell’effetto Ames è visibile a questo indirizzo, https://www.youtube.com/watch?v=YSCUSqRPC1k
Dunque Lilliput e Brobdingnag non fanno che raccontare ai bambini gli inganni della percezione e li rassicurano sull’equivalenza delle difformità.
Una delle citazioni più frequenti e frequentate di Bruno Munari dice: “Per entrare nel mondo di un bambino (o di un gatto) bisogna almeno sedersi per terra”. E resterebbe però ancora molto da fare: aggiungere peso alle piume o alle mele, colorare di azzurro le cose vicine e di blu le cose lontane, disegnare delle scale che scendono ma non salgono e altre che non vanno né su né giù, misurare la circonferenza delle nuvole quando non sono rotonde, stabilire se i fiori sono dolci o salati.

Il nostro mondo fatto di chilometri, metri, decimetri, centimetri e millimetri è misterioso per i bambini, che troverebbero più comodo misurare le distanze in altro modo: ad esempio, lontano è un posto dove non si è mai stati, fosse pure dietro l’angolo, grande è qualcuno che fa la voce grossa anche se è alto come un soldo di cacio.
I bambini di Alberto Manzi, il maestro che con la trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi” inventò l’alfabetizzazione di ritorno, abituati a pensare insieme e a cercare le ragioni profonde dei saperi, la pensavano così:
Bambino: un metro è la lunghezza; serve per misurare una cosa lunga, ce ne sono altri che servono per misurare le cose larghe;
Maestro: serve per misurare anche il vino?
Bambino: non quanti litri di vino ma quanto è alta la bottiglia.
Per misurare servono i numeri, ma quanti tipi di numeri esistono? E che cos’è un numero?
Scriveva Alberto Manzi: “Insegnare matematica non significa insegnare il ‘concetto di numero’ ma aiutare il bambino… a scoprire il numero. Il che significa aver prima chiari tanti altri concetti come quello di quantità, distanza, lunghezza, spazio, classificazione, seriazione”.
Le azioni che il bambino compie adoperando cose e oggetti conducono a questa scoperta, cioè alla scoperta di pensieri concreti: con quanti sassi posso riempire una ciotola? E quanto riso posso mettere poi nello stesso contenitore? E se aggiungo della sabbia, ci sta? E se ora metto l’acqua? Come misuro quanto è capiente la mia ciotola?
Anche la matematica sembra essere nata dagli oggetti, 35.000 anni prima dell’anno zero. Come ci racconta Bruno D’Amore in Arte e matematica, facendoci scoprire “pietre incise a mo’ di macchina da computo, per tenere conto della quantità di oggetti di una raccolta. Così facendo, con 15 tacche su una pietra o su un osso è possibile avere necessità di indicare raccolte di 15 pecore, 15 vasi, 15 frecce…”.
E sembra sia nata, la matematica, insieme all’arte: la spirale, ad esempio, non è solo uno dei primi segni grafici risalenti al Paleolitico ma è anche uno dei primi oggetti di studio dei matematici. Archimede di Siracusa, ad esempio, gli dedica il trattato Sulle spirali. E se capiamo qualcosa di come è cresciuta una chiocciola lo dobbiamo alla spirale logaritmica. La natura mette in moto l’immaginazione che non trova terreno fertile solo nell’arte, ma ha una parte importante nell’invenzione matematica e nella creazione poetica. E ognuna di queste operazioni ci aiutano a dare misura al mondo.

Gli effetti buoni della con/divisione del pensiero.
La giornalista Azzurra D’Agostino propone, con una poesia, di misurare il mondo anche lì dove i numeri sembrano inefficaci e ottusi. Insomma, un’impresa da bambini:
“In matematica non sono brava. Perdo il conto delle foglie dei rami e per le stelle ogni volta ricomincio da capo. Non riesco a misurare il salto delle cavallette e non so la formula per il perimetro delle nuvole. Il calcolo di quanta neve sia caduta mi sfugge e anche di quanta ne possa reggere un filo d’erba. La somma dei passi per arrivare al mare non mi riesce e mi chiedo se per il ritorno devo fare una sottrazione. Ho diviso il numero dei semi per i frutti il risultato è una nuova foresta e ne avanza qualcuno. Se moltiplico le giornate di sole per quelle di pioggia ottengo più di sette stagioni e non so quante settimane. La matematica mi confonde. Come misura del mondo è strana. Per quanti conti si facciano qualcosa non torna mai pari. Due finestre fanno una vista? quattro muri sono una casa? Noi siamo i nostri centimetri, chili, litri? quanto pesa un segreto? quanto misura una risata? e l’area del cuore come si calcola?”






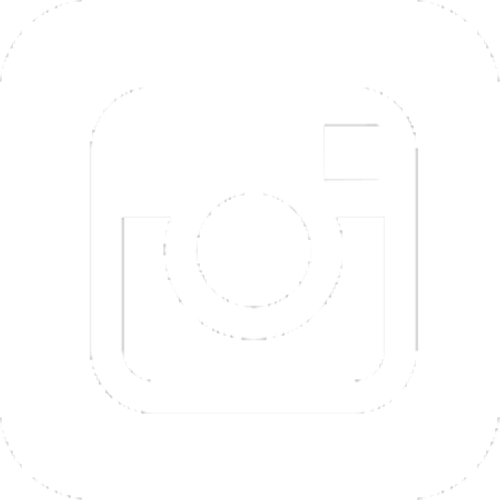
I bambini percepiscono intatta l’opacità del mondo.
Franco Farinelli
“La prima e autentica produzione dello spazio è minuziosamente riportata, fase per fase, nel libro IX dell’Odissea. Si può iniziare dal verso 325, nel quale Ulisse ingiunge di tagliare il verde tronco d’ulivo, l’albero più duro di tutto il Mediterraneo, per la lunghezza di due braccia, le sue. È possibile ottenere tale lunghezza in un modo soltanto: facendo ricorso a quel che Hermann Weyl indica come il primo esempio di concezione geometrica della simmetria, quella bilaterale, cioè la simmetria tra destra e sinistra tipica del corpo umano. La misura del taglio del tronco implica insomma prima d’altro, il meccanismo della riflessione speculare, senza l’intervento del quale il segmento di legno non potrebbe prodursi. Ma una volta prodotto, quest’ultimo non è ancora lineare, perché oltre ad essere il più duro l’olivo è anche l’albero più storto. Deve perciò essere lisciato e sgrossato, quel che appunto Ulisse comanda di fare ai compagni. In una parola, per diventare un’asta il pezzo di tronco deve essere rettificato, in base ad un procedimento mimetico che riguarda non soltanto la dimensione ma anche la forma della coppia d’arti di cui esso diventa copia e allo stesso tempo trasfigurazione. Così nella vera storia della produzione del primo modello spaziale la successione non va dal punto alla linea alla superficie, come dopo Euclide ribadirà Kandisky, ma dalla linea al punto allo spazio. La linea corrisponde al tronco tagliato, lisciato e rettificato. Il punto alla punta che Ulisse in persona aguzza ad una delle estremità, e indurisce alla fiamma. Lo spazio all’esito del cruento scontro tra il signore dell’antro e i prigionieri armati della protesi di legno che serve a offendere e allo stesso tempo a tenere a misurata distanza (letteralmente a ridurre a ragione) quel che appare come «smisurato» e perciò «irragionevole». L’attacco è sferrato soltanto dopo che il mostro si è allungato al suolo, ebbro di vino e sazio di cibo, perciò soltanto quando la sua forma da verticale si è tradotta in orizzontale. Così nell’accecamento due assi o linee grosso modo complanari vengono in contatto: quella del gigantesco corpo steso a terra e l’asta sorretta da cinque tremebondi esseri umani, scaglionati lungo di essa ad intervalli regolari in maniera da costituire una vera e propria scala umana, archetipo e matrice di quella metrica o grafica che ancora oggi distingue con la propria presenza una rappresentazione cartografica da un semplice disegno. Si tratta nel complesso di due diagonali incentrate su un punto d’incrocio alla loro estremità, perché per spingere al meglio il palo nell’occhio è necessario agire secondo un angolo di almeno 45 gradi. E proprio e soltanto perché il suo occhio deve servire da centro Polifemo è un Ciclope, cioè appunto un essere dall’occhio (o dal viso) circolare, la cui forma dunque appare già predisposta ad assumere la funzione di centralità, che in tal modo risulta connaturata. Appunto perché ciò avvenga il perimetro dell’occhio deve «ardere» e le radici «friggere», annichilite dal fuoco e dalla violenta azione meccanica, il cui compito è dunque quello di estirpare ogni dimensione ctonica, sotterranea, riducendo definitivamente la complanarità a superficialità, a dimensione esclusivamente (e letteralmente) geografica. Ancora per secoli il centro così selvaggiamente enucleato e definito scotterà: per questo all’interno della circolare assemblea che costituirà la prima forma di polis, così come all’interno dell’assemblea politica, nessun guerriero o oratore sarà in grado di occuparne a lungo la posizione, ma dovrà dopo poco cederla ad un altro. È nel centro, nell’occhio di Polifemo, che risiede il potere, esso è la sua sorgente, proprio perché è la sua presenza che traduce in spazio ciò che resta del collasso del mondo. Senza la sua preesistenza la linea e il punto non riuscirebbero in tale trasformazione. Ma un centro si dà soltanto se il piano di tale collasso non è quello della superficie terrestre, ma prima ancora quello della materiale rappresentazione di questa. Un centro implica cioè la trasformazione della Terra nella sua immagine. Lo spazio è infatti solo e soltanto la misura del mondo ridotto a tavola: spazio è una parola che deriva dal greco stadìon, che per gli antichi era l’unità di misura delle distanze lineari. Da piccoli non ci hanno insegnato nulla. O meglio, ci hanno insegnato a fare le cose senza avere più nessuna memoria del loro significato. Nessuno ci ha mai spiegato che le aste con cui siamo stati introdotti al mistero della scrittura erano le lance dei guerrieri. Nessuno ci ha mai spiegato che ogni volta che squadriamo un foglio produciamo lo spazio, e torniamo perciò come Ulisse ad accecare Polifemo, o almeno torniamo a compiere il rito che da tale scontro deriva.”